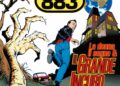Il baccalà e lo stoccafisso sono spesso percepiti come cibo “povero”, o addirittura “di ripiego”, rispetto al pesce fresco. La sesta edizione di Roma Baccalà, nel rinnovato Parco Schuster, ha messo questo pregiudizio sotto una lente, trasformando una festa popolare in un laboratorio di idee su gusto, identità e sostenibilità.
Camminare tra gli stand significa attraversare una geografia gastronomica che va dal Veneto alle Marche, fino al Sud, ognuno con la propria grammatica del sale, dell’essiccazione e delle salse: baccalà alla vicentina, tortino marchigiano con cipolle di Acquaviva, maritozzo con baccalà mantecato. Al centro, un palco di showcooking e talk costruisce un discorso continuo: non si tratta solo di ricette, ma di pratiche alimentari nate per nutrire in condizioni difficili, diventate oggi patrimonio di gusto.
L’innesco arriva quando il festival accoglie i Sami, popolazione indigena della Norvegia che vive da secoli di pesca al merluzzo. Accanto alla loro bandiera, i rappresentanti raccontano una tensione che riguarda tutti: la tradizione dello stoccafisso essiccato – stabile, trasportabile, democratico – è compressa dall’egemonia commerciale del merluzzo fresco, venduto a prezzi alti e caricato di un immaginario “nobile”.

Qui interviene la Confraternita dello Stoccafisso – tonaca compresa – che attraversa l’Italia per mostrare la logica di un alimento candidato a bene immateriale UNESCO: il “Bang Bang Stockfish”, il gesto di battere il pesce essiccato con un martello di legno per renderlo tenero, è un atto tecnico ma anche simbolico. Comunica che il cibo non è solo materia: è rito, memoria, adattamento. E davanti a una fiskesuppe Sami – la zuppa artica di pesce – molti visitatori scoprono che ciò che pensavano “asciutto” o “difficile” diventa, in brodo, confortante e familiare. Il palato si educa, e con lui l’idea di ciò che è accettabile.
Il festival non idealizza nulla: affianca alle storie del Nord le cucine di prossimità dei mercati rionali romani. Lì l’empanada di baccalà o la “gricia di baccalà” non sono provocazioni, ma soluzioni quotidiane che nascono al banco e vi ritornano. È un promemoria: le nostre preferenze non sono mai puramente individuali, ma il prodotto di abitudini, disponibilità e linguaggi. Se un filetto fritto alla romana evoca casa, il suo valore non dipende da quanto sia “nobile” la specie, ma da quanto è integrato nella vita delle persone che lo cucinano.

La Calabria porta un’altra lezione: stoccafisso, olio extravergine, funghi dell’Aspromonte, pasticceria tipica. Il “Gambero Gobetto” raccontato dallo chef Riccardo Sculli è l’esempio di quanto conoscenza e selezione possano orientare la pesca verso scelte più responsabili.
Un altro capitolo riguarda l’inclusività: un menu totalmente gluten free (in collaborazione con AIC Lazio) e uno spettacolo “green” per bambini ricordano che cambiare il sistema alimentare significa anche rimuovere barriere pratiche e simboliche. Il cibo è socialità, e non c’è socialità se qualcuno resta fuori.
C’è poi la questione dell’estetica del cibo. Il fresco luccica, l’essiccato sembra severo; la salsa cremosa rassicura, il sale e il legno parlano di lavoro. È qui che un festival serve: offre esposizione guidata. Vedere mani esperte battere lo stoccafisso, assaggiare un brodo che ne trasforma la consistenza, ascoltare chi spiega perché quell’essiccazione nasce dal clima e non dalla povertà: tutto questo smonta il pregiudizio meglio di mille definizioni.

Che cosa rimane, allora? L’idea che tradizione e innovazione non siano opposti. Il Seafood Norwegian Council porta una ricetta “nuova” (baccalà norvegese con salsa cremosa alla pancetta e purea di patate) che parla un linguaggio familiare. Le osterie reinterpretano la memoria senza musealizzarla. I Sami ricordano che dietro ogni filiera ci sono comunità reali, che rischiano di essere spazzate via quando il mercato e l’immaginario vanno in un’unica direzione.